




|
|
|
|
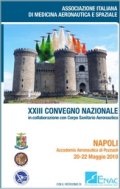
Abstract
STUDIO DELLE RELAZIONI SONNO-STRESS NEL MODELLO SPERIMENTALE MARS 500
Angelo Gemignani(1),(2), Remo Bedini(1),(3)
(1)Centro Extreme, Scuola Superiore S’Anna, Pisa.
(2)Dipartimento di Scienze Fisiologiche, Università di Pisa.
(3)Istituto di Fisiologia Clinica, CNR, Pisa
Introduzione. Gli astronauti coinvolti in missioni spaziali di lunga durata rappresentano un modello di studio per la valutazione degli effetti dello stress cronico indotto da condizioni ambientali estreme. In particolare è stato dimostrato come le alterazioni del sonno indotte da elevati livelli di stress rappresentano la causa di incidenti ed accidenti che possono compromettere la missione.
Scopo. Lo scopo di questo studio (ARES, Astronauts Resistance Enhancement to Stress) è stato quello di valutare la modulazione svolta dallo stress (indotto da isolamento sociale, emergenze simulate, rumore ambientale) sull’assetto emotivo, sulle funzioni cognitive e sul sonno (in particolare sulla Sleep Slow Oscillation - SSO) nell’uomo nel modello sperimentale della simulazione del viaggio sul pianeta Marte (progetto MARS 500, fase MARS 105).
Materiale e Metodi. Le funzioni neuro-psicologiche (cognitive e emotive) e il pattern neurovegetativo (ECG, respirogramma ed attività elettrodermica) e polisonnografico (EEG ad alta densità) sono state studiate in 6 astronauti. Lo studio del sonno è stato affrontato mediante analisi della struttura e del mapping della Sleep Slow Oscillation (SSO), i livelli di stress mediante analisi dei livelli tonici di cortisolo urinario, dell’equilibrio simpato-vagale e dei punteggi della Perceived Stress Scale, l’assetto cognitivo mediante l’analisi di alcune sottoscale della Wechsler Adult Intelligence Scale (ripetizione di cifre, completamento di figure, associazione di simboli a numeri), del Test di Corsi e i cubi di Kohs, l’assetto emotivo mediante il Profile of Mood State (POMS). Lo studio delle funzioni cognitive ed emotive è stato effettuato prima (BDC, Basal Data Collection) e dopo il volo simulato (RDC, Recovery Data Collection), mentre lo studio del sonno e dei livelli di stress prevedeva, oltre alla BDC e RDC, anche tre valutazioni all’interno del simulatore (I, II, III, una ogni mese per 105 giorni).
Risultati. I risultati indicano che la condizione di simulazione non induce alcuna modificazione delle funzioni cognitive e emotive. Il principale risultato di questo studio è che le origini e le detezioni delle SSO sono inversamente proporzionali ai livelli di cortisolo, particolarmente nelle regioni fronto-centrali. Inoltre è stato osservato che anche la durata del sonno ad onde lente (stadio 3 e 4 del NREM, Slow Wave Sleep, SWS) del primo ciclo di sonno e della latenza REM correlavano negativamente con i livelli di cortisolo.
Conclusioni. Da questo studio emerge una stretta relazione tra livelli di stress e alterazioni della SSO, cioè di un meccanismo alla base delle funzioni omeostatiche del SWS. Questo aspetto assume una dimensione rilevante considerando l’alterazione della SSO come una condizione borderline, ancora priva di manifestazioni cliniche nosograficamente distinte.
Questo aspetto, inoltre, pone lo studio della SSO e delle sue proprietà come cruciale al fine di identificare indici predittivi di rischio di evoluzione prepatologica.